Zoom-In – Dentro le visioni di chi crea - 3ª puntata con Francesco Costabile
Per la 3ª puntata del nostro format di interviste scopriamo il percorso di Francesco Costabile, il regista e sceneggiatore che con il suo ultimo film, Familia, rappresenterà l’Italia agli Oscar 2026.

Dopo la pausa estiva torniamo con la 3ª uscita di Zoom-in, il nuovo format di interviste targato Giovazoom che mette a fuoco le storie di chi, con passione e sacrificio, ha costruito il proprio percorso nel mondo dell’arte, della cultura e della creatività.
Per questa nuova puntata tutta autunnale abbiamo intervistato Francesco Costabile, regista e sceneggiatore di origine calabrese - ma bolognese d’adozione - il cui ultimo film, Familia, è stato selezionato per rappresentare l’Italia agli Oscar 2026 nella categoria di Miglior Film Internazionale.
Esordiente nel 2001 con il cortometraggio La sua gamba, vincitore del Bellaria Film Festival, Costabile vince il Nastro d’Argento al Miglior Cortometraggio con Dentro Roma, per poi dedicarsi al format documentario. Il suo esordio nel cinema fiction è Una femmina: ispirato al libro inchiesta Fimmine ribelli di Lirio Abbate, il film racconta le donne vittime di violenza nelle famiglie della Ndrangheta calabrese; presentato in concorso al Festival di Berlino 2022, riceve due candidature ai David di Donatello 2022, due candidature ai Nastri D'Argento e vince due Globi d'oro.
Ispirato al libro Non sarà sempre così di Luigi Celeste, Familia narra le vicende di una famiglia alle prese con il dramma di una vita vissuta alla mercé di un uomo violento. Presentato in concorso nella sezione Orizzonti all'81ª Mostra del Cinema di Venezia, vince il premio per la Miglior Interpretazione Maschile (Francesco Gheghi); il film è stato inoltre candidato a 8 David di Donatello nel 2025 e ha vinto il David nella categoria Miglior Attore Non Protagonista (Francesco Di Leva).
Partiamo dalle origini: cosa ti ha spinto a intraprendere la strada del cinema? C'è stato un momento o un incontro che ha fatto scattare la scintilla?
La scintilla mi è scattata quando ero bambino. A 9 anni ho visto per la prima volta in tv I Segreti di Twin Peaks di David Lynch: quella serie mi ha spalancato un mondo, ho visto per la prima volta qualcosa che mi attraeva, ma anche mi spaventava, perché quello di Lynch era anche un mondo oscuro e violento. Ho avuto questa folgorazione grazie alla quale ho avuto la spinta per iniziare a creare anche io dei miei mondi; poi, sempre attraverso Lynch, mi sono avvicinato al cinema, ho iniziato a vedere altri film, a cercare film d’autore da registrare dalla tv; io abitavo in Calabria, all’epoca c’erano pochi cinema e quelli che c’erano avevano una programmazione molto commerciale; ho iniziato a guardare Fuori Orario e a studiarmi i palinsesti televisivi, a volte addirittura mi svegliavo la notte o programmavo dal videoregistratore i film da registrare. Il cinema è stato sin da piccolo la mia valvola di sfogo, la mia fuga da una realtà piuttosto opprimente.
La tua storia con il cinema parte dal laboratorio sperimentale di Flashvideo Bologna cui hai partecipato nel 2001 insieme, tra gli altri, al regista Francesco Amato. Grazie a quel corso è poi stato realizzato La sua gamba, corto vincitore del Bellaria Film Festival nel 2002. Mi racconti un po’ di come hai vissuto quegli anni di sperimentazione? C’è qualcosa che ti porti nel cuore di quei momenti?
Bologna era splendida. Vivevamo nel centro storico e la città era in mano agli studenti: questa cosa era bellissima perché anche l’elemento della socialità e della comunità era molto importante, ci si conosceva tutti. Francesco Amato era mio amico, il mio vicino di casa era Cosimo Terlizzi, frequentavamo il teatro sperimentale dell’epoca, il Teatrino Clandestino. Era una città dove respiravi cultura e arte. Lì mi sono immerso nella mia passione e sono riuscito così a sviluppare le mie idee e i miei progetti sperimentali di cortometraggi. Venivo dall’immaginario Lynchiano e quindi usavo il cinema come forma d’arte, poi La sua gamba è probabilmente stato il mio primo corto con una confezione più narrativa - anche se grottesca - e infatti è stato fondamentale per entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Negli anni più maturi, dopo gli studi al CSC, sei andato avanti con il genere documentario e poi hai fatto due film tratti entrambi da storie vere. Da dove nasce questo attaccamento al reale?
È nato in maniera spontanea come evoluzione da un cinema di astrazione: col tempo ho capito quanto la realtà sia un linguaggio, come diceva Pasolini. La realtà va letta e interpretata, la realtà non ha nulla di realistico, è manifestazione di qualcos’altro… direi che è stato il mio amore per Pasolini a farmi avvicinare alla narrazione del reale. Già con il mio saggio di diploma al CSC, Dentro Roma, mi ero impegnato a fare opere d’impronta sociale e civile; gli artisti sono sempre un po’ figli del loro tempo, quindi è giusto che il nostro immaginario sposi ciò che ci circonda e incontri altre soggettività.
Nei tuoi film si impone una certa attenzione per il dettaglio, il primo piano, la valorizzazione quasi ossessiva degli sguardi e delle micro-espressioni. Come lavori su questi aspetti con i tuoi attori e con la costruzione dell’atmosfera filmica?
Parlando di scenografia lavoro sempre sugli spazi, sulle architetture e sugli ambienti come se fossero dei personaggi, cercando un carattere che in qualche modo rispetti il tema del film, anche nella sua palette colori. Il paese di Una femmina, per esempio, è un po’ un’emanazione della violenza che la protagonista vive nella sua famiglia. Per quanto riguarda gli attori, mi interessa ciò che succede dentro e non fuori: mi interessa il pensiero, quello che avviene nella loro emotività. Questo determina un po’ lo stile di regia, che è molto vicino ai corpi e alle facce, e se è distante diventa tale perché è il paesaggio che parla per l’attore.
Familia è uscito ormai quasi un anno fa. Com’è stato il viaggio del film nelle sale italiane e quale è stata l’accoglienza da parte del pubblico?
Il film piace moltissimo e devo dire che accompagnarlo mi ha sempre arricchito molto, mi ha dato stimoli e punti di riflessione in merito al tema del film e alla sua attualità. Le presentazioni del film nelle sale sono sempre momenti in cui mi confronto con la riuscita o meno del film e capisco se quello che ho fatto ha senso o no. L’ago della bilancia lo dà sempre l’emozione del pubblico: se gli spettatori si sono emozionati, penso di aver fatto un buon film. Anche per i più giovani ho fatto diverse presentazioni e di certo Familia non è il solito film che sono abituati a vedere. Mi sono però reso conto, con l’esperienza, che i ragazzi hanno necessità di trattare determinati temi e questo film permette a insegnanti e adulti di fare entrare nelle scuole quella materia che continua a non esserci, ovvero l’educazione affettiva e sessuale. Dobbiamo ricordarci che quando si parla di violenza di genere si parla anche di cultura del possesso, cultura patriarcale, quindi i ragazzi sono molto reattivi, proprio per il loro desiderio di confrontarsi su questioni che vivono in prima persona, spesso senza educazione o guida. L’educazione è l’unico modo che abbiamo per arginare questo fenomeno così drammatico, bisogna partire necessariamente dai ragazzi.
Cosa pensi abbia fatto la differenza nella decisione di selezionare Familia come opera rappresentativa dell’Italia agli Oscar 2026?
Credo che sia stata la tematica a fare la differenza, e anche il periodo storico che stiamo vivendo. A suo modo è stata anche una scelta politica, cioè portare in America un film che indaga l’origine della violenza in una cultura estremamente patriarcale e violenta, che è un po’ quello che anima oggi l’America di Trump.
Tu sei anche docente di grafica alle scuole Aldini Valeriani di Bologna. In che misura due mestieri così diversi tra loro si influenzano a vicenda (se lo fanno)?
Si certamente, si incontrano perché anche il nostro vissuto alimenta ciò che creiamo. L’attività del docente mi ha permesso non solo di avere un’autonomia economica, ma mi ha anche garantito l’ancoraggio alla realtà, cioè l’avere un lavoro che mi permette di confrontarmi con la vita vera, con i ragazzi e con il loro mondo. Non sono mai stato rinchiuso in una bolla sociale, sono sempre stato e continuo a essere in comunicazione col mondo.
Ai giovani spesso si dice che devono scegliere “un’unica strada” per il futuro. La tua biografia racconta invece di un percorso che si dirama non solo in più generi cinematografici e ruoli, ma anche in mestieri completamente diversi tra loro. Che consiglio daresti a un giovane che oggi cerca la propria direzione?
La cosa fondamentale è seguire la propria passione, innanzitutto è necessario individuarla. Per fare arte e cinema è indispensabile una vocazione, perché è un mestiere difficile, si è senza soldi, è difficilissimo sopravvivere, dunque è necessaria una grande determinazione che non può che essere animata da una passione inesauribile, un’ostinazione, una vocazione appunto. Se invece si sceglie di intraprendere questa strada convinti di andare a fare un lavoro come tanti altri non si dura molto, anche perché in questo percorso professionale è sempre necessario mettersi in discussione, è necessario accettare fallimenti come possibilità di crescita, quindi è fondamentale avere già una predisposizione a questo tipo di approccio.
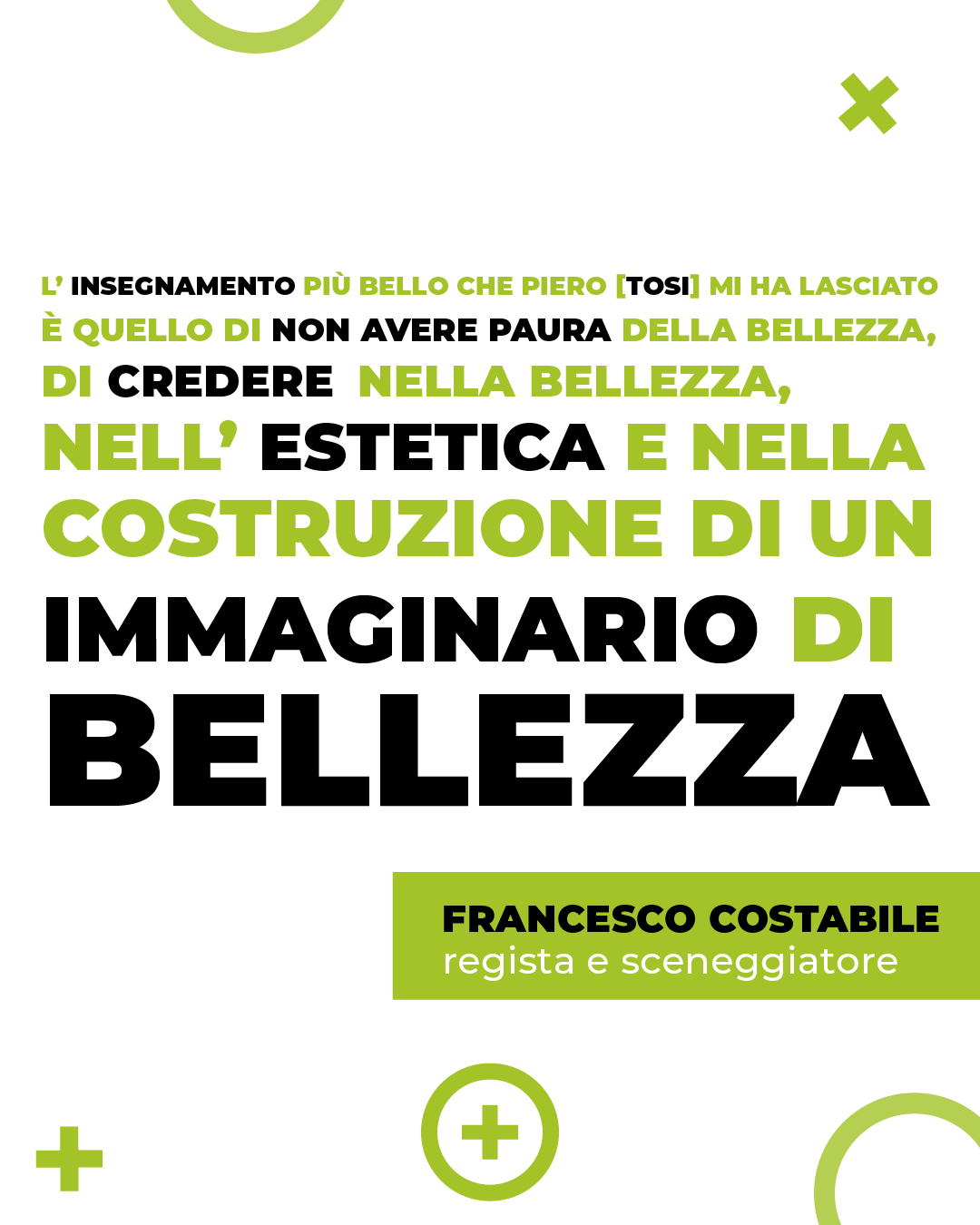
Quali sono i tuoi maestri, i tuoi punti di riferimento, le persone o le opere che ti hanno insegnato a raccontare il mondo?
Io dico sempre che l’unico maestro che ho avuto in vita è stato Piero Tosi, il grande costumista di Luchino Visconti (e non solo), su cui io ho anche fatto un paio di documentari. Piero è stato mio insegnante del corso di costume al Centro Sperimentale, e con lui è nata un’amicizia profonda che mi ha riempito il cuore e mi ha fatto capire anche tante cose in merito alla composizione e all’immagine. L’insegnamento più bello che Piero mi ha lasciato è quello di non avere paura della bellezza, di credere nella bellezza, nell’estetica e nella costruzione di un immaginario di bellezza. Spesso si ha paura di creare un’estetica della bellezza perché si ha il terrore di cadere nell’estetismo, che è effettivamente un rischio, però purtroppo la contropartita di questa paura è l’appiattimento, il naturalismo sciapo, che poi rischia di essere televisivo, omologante e convenzionale.




