Zoom-In – Dentro le visioni di chi crea - 2ª puntata
Per la 2ª puntata del nostro format di interviste scopriamo il percorso di Claudio Jampaglia, giornalista, podcaster, documentarista innamorato della comunicazione e delle sue infinite potenzialità

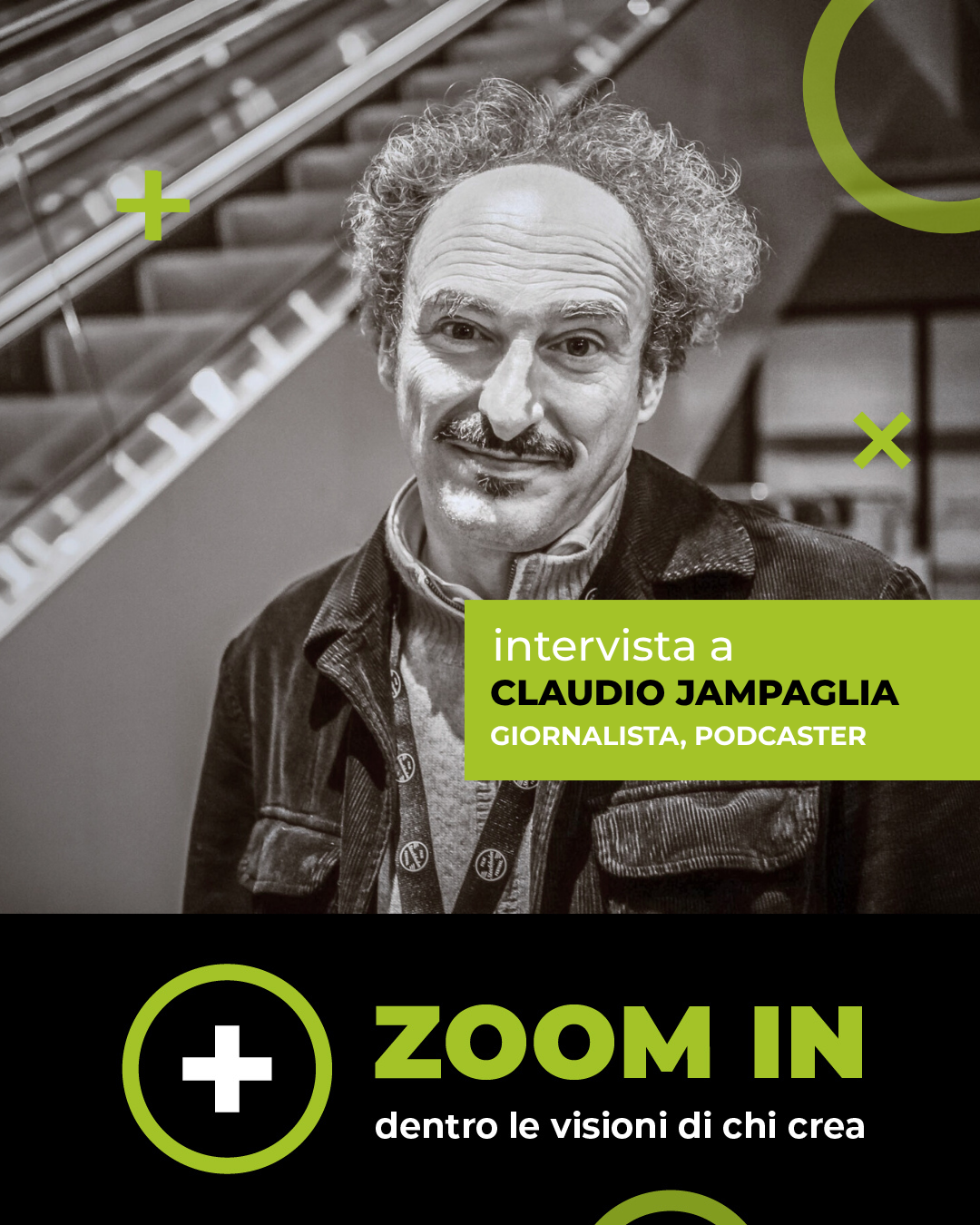
Eccoci tornati con la seconda uscita di Zoom-in, il nuovo format di interviste targato Giovazoom che mette a fuoco le storie di chi, con passione e sacrificio, ha costruito il proprio percorso nel mondo dell’arte, della cultura e della creatività
Abbiamo intervistato Claudio Jampaglia, giornalista, autore, documentarista e voce storica di Radio Popolare, dove oggi è caposervizio del radiogiornale Metroregione e co-autore di podcast come Andrà tutto bene, Memorie di inciampo, Fiori di primavera, La strada nel bosco, Ci insegnavano la guerra, volevamo la pace. Il suo percorso attraversa radio, carta stampata, televisione e audiovisivi, sempre con uno sguardo lucido e appassionato su conflitti, trasformazioni sociali e memorie collettive. Ha collaborato con Presa Diretta (Rai3), scritto per L’Espresso, Vanity Fair, Il manifesto, diretto documentari come Our War (73ª Mostra del Cinema di Venezia) e prodotto I Am the Revolution della documentarista Benedetta Argentieri, distribuito ad oggi in oltre 20 Paesi. Ha sviluppato campagne di comunicazione, video e installazioni per realtà come il Corriere della Sera, il Muse – Museo delle Scienze di Trento, UniCredit l’Università di Milano e quella di Cagliari. Con Emergency è anche co-autore del format Guarda che Lune, dedicato al rapporto tra comunicazione, media e marchi, oggi diventato talk teatrale.
Partiamo dalle origini: cosa ti ha spinto a intraprendere la strada del giornalismo? C'è stato un momento o un incontro che ha fatto scattare la scintilla?
Io ho un percorso abbastanza atipico. Adesso si diventa giornalisti prevalentemente tramite l’università, ma ai miei tempi l’università aveva solo dei corsi post o pre-università legati al giornalismo, poi c’era il professionismo e il praticantato. Sin da giovanissimo ho avuto la passione per le questioni che riguardano la politica internazionale, il mondo, la geografia, le guerre e i popoli. Mi sarebbe piaciuto viaggiare e conoscere queste realtà, quindi già al liceo ho iniziato a fare giornalini scolastici e agitarmi con collettivi e compagnie di amici.
Per me ci sono due modi di esplorare: esplorare per ricercare, e quindi si parla di scienza e di conoscenza, poi c’è l’esplorazione finalizzata al racconto, che è una cosa molto diversa. Io sono partito da questa voglia di esplorare per raccontare: ho avuto la fortuna di conoscere, già da ragazzino, una radio comunitaria e alternativa che apriva le porte a giovani tra i 16 e i 18 anni che raccontavano la cronaca delle loro scuole e delle altre scuole della città, era Radio Popolare. Poi sono passato da Radio Onda D’urto e da Italia Radio e quindi ho frequentato sempre posti aperti a giovani che magari non avevano ancora il mestiere, ma avevano voglia di raccontare e imparare un po’ di strumenti. Ho appreso in questo modo un metodo e un mestiere: sul campo, attraverso seminari autogestiti, lavori di gruppo e così via.
Ciò che alla fine mi ha spinto veramente a fare il giornalista è stata la bocciatura al percorso da diplomatico: nonostante io fossi già freelance, subito dopo la laurea in Scienze Politiche ho provato a fare il concorso per diventare diplomatico e non ce l’ho fatta. Quindi mi sono messo ad andare in giro a scrivere: ho deciso di andare a lavorare all’estero nella mia ditta di famiglia che, storicamente, gestiva cantieri relativi a infrastrutture legate all’acqua in Marocco. Lavoro lì e viaggiando molto riesco comunque a scrivere e registrare pezzi di radio direttamente dall’Africa. Nel 2001 mi prendo un anno sabbatico dal lavoro e milito in un’associazione che si chiama Attac!, della quale gestisco strumenti comunicativi, soprattutto una newsletter con 45.000 iscritti nel periodo del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua. Così capisco che la comunicazione tradizionale è la cosa che mi piace di più. Finito l’anno dei movimenti, mi faccio assumere dal quotidiano Liberazione, per il quale lavoravo da freelance: faccio il praticantato e poi l’esame per diventare giornalista professionista. Nel giro di un paio di anni passo da praticante a capo-redattore, stesso ruolo che avrò poi per il mensile Diario; subito dopo inizio a fare documentari e apro una mia società di produzione di documentari, con la quale capisco che non riesco a sopravvivere. Allora decido di tornare all’origine: torno a Radio Popolare, dove mi assumono per una sostituzione estiva e dove poi decidono di tenermi. E questo è solo l’inizio…
La tua carriera attraversa radio, televisione, carta stampata, documentari, podcast. Cosa ti guida quando scegli un nuovo linguaggio per raccontare una storia?
Per me la cosa più importante è riuscire a stare dentro un meccanismo creativo e autoriale: qualunque cosa scrivi sei un autore, e io credo molto in questo. Quando arrivano nuovi giornalisti o stagisti in radio, io guardo tantissimo alla loro parte creativa, persino nei pezzi di cronaca, perché un pezzo di cronaca bello è quello che ha dentro una parola solo tua. Io sono innamorato della fase creativa e delle specificità di tutti i linguaggi, e la cosa bella non è tanto rendersi conto delle differenze di questi mestieri, ma sperimentare, praticarle, non rinunciare al fatto che a ogni switch di linguaggio è necessario ritarare il proprio metodo e reinventarsi. Per esempio il podcast ha una parte di montaggio, ha una parte di concept, ha una parte di scrittura, ha una parte di rigore, ha persino una parte di fantasia, ma ogni passaggio dev’essere vissuto, ragionato. E la cosa più interessante di tutte è ragionare sull’intenzione: se tu sai dentro di te perché senti il bisogno di raccontare e dire proprio quella cosa lì, la tua motivazione nella narrazione è la tua intenzione; questo è un lavoro importante che devi fare su te stesso, oltre che sul materiale che hai raccolto. Spesso si dice che lavorare nel giornalismo significa lavorare sugli altri: certo, devi rispettare le persone di cui parli, non devi giudicare la loro storia, ma sei tu che sei chiamato in prima persona a raccontare, e il tuo coinvolgimento prevede che tu ti interroghi, che tu crei e che di conseguenza lavori su te stesso per donare a tutti quel tuo pezzo, quella tua intenzione.
Poco fa hai citato il podcast, che come format oggi sta vivendo una stagione particolarmente fortunata e si sta contaminando anche con il video e con altre forme artistiche, più o meno motivatamente. Secondo te quanto è importante oggi reinventarsi e innovare nel mondo dell’informazione?
Io mi sarei aspettato che nel corso degli ultimi anni sarebbe emersa più complessità e più qualità nella produzione di contenuti. Mi immaginavo che la costruzione di un reportage fatto con uno smartphone, con il quale puoi lavorare a video, audio, scrittura, montaggio, grafica e quant’altro mentre sei sul campo sarebbe stato un linguaggio, peraltro già pronto 10 anni fa, capace di raccontare storie incredibili con metodi mai visti prima. E invece non è successo: siamo pieni di gente che non si sa a che titolo si mette davanti alla telecamera e racconta qualsiasi cosa al microfono, eppure saranno i milioni di clic a giudicare la qualità di questo lavoro. Questa è una bellissima libertà, e come tutte le libertà è viva, quindi non la giudichiamo, però la libertà non può corrispondere a liceità, non può essere soltanto dire «io sono libero di accendere la camera e dire quello che voglio», quanto piuttosto, come diceva la partigiana Claudia Ruggerini, la libertà vera è prendersi responsabilità delle cose, è un fatto collettivo e in continua discussione comune. Invece di montare nella loro cameretta davanti a un microfono da 1000 euro, perché questi giovani creativi non escono per strada e mi raccontano la vita vera, poi la montano e mi fanno un prodotto che io posso utilizzare per capire un po’ meglio la realtà? Noi non sappiamo come loro vedono il mondo, come lo vivono e non lo capiamo fruendo prodotti creati da persone che nella vita sono sedute, parlano tra di loro e fanno il giornalismo in una stanza. È un po’ asfissiante.
Nei tuoi documentari e nelle tue campagne si percepisce un forte impegno civile e sociale. Da dove nasce questa spinta a raccontare il mondo dal basso, di narrare anche quei conflitti che spesso vengono dimenticati o che i media raccontano in modo superficiale?
Io credo che il giornalismo di carattere oggettivo esista poco e non mi convince molto come approccio. C’è un’oggettività di alcuni fatti e dibattiti, e questo è indiscutibile perché la verità è la verità, ma non sta lì il punto. Il punto vero sta nel dolore: dentro tutte queste storie c’è quasi sempre una densità di dolore che viene paracadutato sulla vita delle persone, così come nelle loro relazioni fatte di traumi, conflitti e soprusi. Il mio interesse come giornalista, dunque, non può che avere a che fare con la violenza: non violenza intesa solo ed esclusivamente nel senso bellico, ma nel senso più quotidiano e nascosto, come quella subita dalla gente che muore sul lavoro, per esempio. Penso che il mistero che mi affascina muova dal desiderio che questa violenza abbia una spiegazione, abbia non una punizione, ma una catarsi, che almeno qualcuno la possa raccontare. Penso che al fondo ci sia la necessità di guardarla nel profondo, e quindi di raccontarla, anche per restituire in qualche misura un senso di giustizia.
Com’è stata la tua esperienza con il lavoro televisivo dentro Presa Diretta?
Ho lavorato a una sola puntata di Presa Diretta con Iacona e tutta la redazione, una collaborazione che è durata circa quattro mesi. Io lavoravo già al Diario e avevo una specialità nelle inchieste giudiziarie; loro cercavano un giornalista giudiziario che gli costruisse una puntata sul Palazzo di Giustizia di Milano. Allora mi è stato chiesto, è andata molto bene, ma io ho capito la tv non è tanto il mio ambito; rispetto al mio mondo del documentario è molto diverso, c’è un grande rito della produzione da canale televisivo che mi ha dato l’impressione di lavorare da indipendente ma nel mainstream, non so se è chiaro il parallelismo. Poi in redazione ci sono fior fior di professionisti, agguerritissimi e con un grande desiderio di raccontare storie, però comunque hai molte regole e sei calato dentro una gerarchia che devi saper rispettare.
Che rapporto hai con il fallimento?
Fallire vuol dire imparare, si sbaglia e si migliora. Io sono motociclista, quindi se casco o mi rompo o mi rialzo. Se ti rompi hai bisogno di tempo per rimetterti in pista, altrimenti ti rialzi e ricominci daccapo. Sul lavoro ho avuto poca esperienza di fallimento, i miei fallimenti sono più umani: aver perso quella persona, non aver detto abbastanza o aver detto poco a qualcuno, per lo più i miei fallimenti più profondi hanno a che fare con le persone.
Ai giovani spesso si dice che devono scegliere “un’unica strada” per il futuro. La tua biografia racconta invece di un percorso ricco, poliedrico. Che consiglio daresti a chi oggi cerca la propria direzione?
Ci sono persone che sanno cosa devono fare, ce ne sono altre che devono cercare per sapere cosa fare. Io appartengono alla seconda categoria, ma devo dire che sono molte, moltissime le cose mi interessano e mi piacciono, mentre spesso chi ha in testa una cosa, non ha molta flessibilità. Se fate parte della categoria dei cercatori, il tema è, ahimè, quello di una poetica condanna: non possiamo smettere di cercare. Ci sono però una serie di criteri da rispettare: il primo è che sei quel che sei. Cioè non puoi esser di più, ma non puoi essere neanche di meno. Io ho dei limiti e quei limiti devono conoscerli per capire fin dove posso spostarli in avanti e indietro, e anche quando invece devo accettarli e basta. Allo stesso tempo però non sono di meno: io so che posso scrivere una cosa a determinate condizioni, con un buon ascolto, una buona rappresentazione, questo so farlo e lo faccio.
Secondo, scegliere sempre qualcosa che ti permette di vedere cosa sai fare, di misurarlo: quindi accettare sempre le belle sfide, anche quelle che ti mettono in condizioni difficili; non accettarle significa non provare la necessità di conoscere e di migliorare. Terzo, sempre e in ogni caso praticare la sospensione nel giudizio: giudicarsi e giudicare è una delle cose più inutili che ci siano; io ho avuto direttori che non mi hanno capito, ancora adesso so di non avere il riconoscimento che vorrei, eppure non devo giudicare gli altri perché non mi capiscono come vorrei. È necessario avere un po’ di umiltà di capire che il mondo gira in un modo grazie a un serie di tantissime serie di complicanze, relazioni e correlazioni: non sempre sei tu la complicanza o il fulcro intorno al quale ruota tutto. In ogni caso è necessario fare il proprio mestiere, non mancare mai al proprio dovere.
In ultimo è importante prendersi la propria responsabilità: è difficilissimo, è un momento in cui anche per i giovani pare che non ci sia un posto reale, ma non è così. Ho visto tantissimi giovani arrivare in radio e prendere con difficoltà una strada che era la loro anche se non l’avevano vista. Allo stesso tempo ci vuole un po’ di politica, un po’ di mettere in comune, un po’ di sogno: non siamo noi quelli interessanti, se continuiamo a guardarci l’ombelico non andiamo molto avanti, dobbiamo toglierci dalla mente l’idea di dover misurare le cose partendo solo ed esclusivamente dal sé. È una prospettiva limitante e in quest’epoca ce l’hanno cucita addosso, quello che conta invece sono i processi collettivi. Tutto è incentrato sul singolo, sul voto, sulla competenza, sull’occasione persa: ma una volta che uno rispetta le regole che ti ho detto l’individuo è a posto. Il problema è partecipare a qualcosa con gli altri, stare dove succedono le cose e dove si fanno le trasformazioni, è lì che si mette in comune davvero.

Insegni comunicazione e innovazione sostenibile: che responsabilità credi abbiano oggi le nuove generazioni nella costruzione di una società più giusta, informata e consapevole?
Hanno la stessa che avevamo noi. Tocca a loro decidere cos’è la società e trasformarla, io l’ho già detto tante volte, ormai sono lento e fuori tempo. A me interessa moltissimo osservare questa dinamica, perché mi fa capire come tante cose esistono e vengono percepite in maniera diversissima da come le avrei in mente io. Per me è inevitabile quel mettere in comune: molto più di ieri, oggi il trattamento del dato è a rischio di potere e di denaro gravissimo, e questo ci rende tutti piccoli e schiavi delle stesse idee e delle stesse bolle di informazione pilotate. Quello che io mi augurerei è che ci sia una generazione di giovani che si rende conto che questo sistema è un sistema deleterio, per cui è necessario tornare a un sistema di relazioni vere e di messa in comune. Ma lo diranno loro.
Quali sono i tuoi maestri, i tuoi punti di riferimento, le persone o le opere che ti hanno insegnato a raccontare il mondo e ad essere quello che sei, umanamente e professionalmente?
Nella propria vita si hanno, nel bene o nel male, dei genitori, una famiglia, degli amici e dei compagni di viaggio e io di questi sono sempre molto grato e contento. Se devo dirti delle cose più specifiche, ti dico che la scuola pubblica è la mia maestra, i miei docenti mi hanno aperto la testa e mi hanno insegnato a guardare oltre: ho avuto una docente di lettere al ginnasio, Teresa Ciccolini, che mi ha insegnato il valore della cultura come strumento collettivo, intellettuale, prezioso e mai elitario. Da lei ho imparato che il senso della nostra identità di singoli non esiste se non nella memoria collettiva e nell’incontro con le storie degli altri.
Inoltre ho tanti maestri immaginari: film, libri, documentari, se posso io scelgo sempre la poesia per prima, perché poi sempre lì torno. Poi io sono un po’ contrario ai maestri intesi nel senso classico del termine, sono convinto che si prende qualcosa da tutti quelli con cui si ha avuto a che fare, dal primo che mi ha acceso un microfono al mio amico Bruno che è qui con me. E spero di poter dare qualcosa anche io agli altri, proprio come gli altri hanno fatto e continuano a fare con me.



